Il Cafisc centro di alta formazione investigativa strategia e criminologia nell’ambito della più ambia gamma di offerte dell’ Ass. Cafisc EJ Upecej tra formazione continua in moti settori con Upecej
Tag: Sicurezza
Sicurezza e cittadinanza 57° Rapporto Censis 2023Sicurezza e cittadinanza 57° Rapporto Censis 2023
Un mercato del lavoro che non può fare a meno degli stranieri. Nei prossimi tre anni saranno ammessi in Italia attraverso il “Decreto flussi” 452.000 cittadini stranieri, un numero decisamente
I segreti che tutti vorremmo conoscereI segreti che tutti vorremmo conoscere
In mostra a Londra oggetti come la telecamera nascosta in un rossetto e tutto ciò che vorremmo sapere sui servizi di Intelligence più noti nel mondo come MI6, CIA e

Le linee guida e le raccomandazioni dell’EIGE nella valutazione del rischioLe linee guida e le raccomandazioni dell’EIGE nella valutazione del rischio
Valutazione del rischio e gestione della violenza da parte del partner nell’UE Gli agenti di polizia svolgono un ruolo di primo piano nella riduzione della violenza contro le donne da

Spionaggio e controspionaggioSpionaggio e controspionaggio
Jean-Pierre Alem – (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984) Il volume, pubblicato in lingua originale in Francia nel 1980 e apparso nella traduzione italiana curata dalle Edizioni scientifiche Italiane, nel 1984,
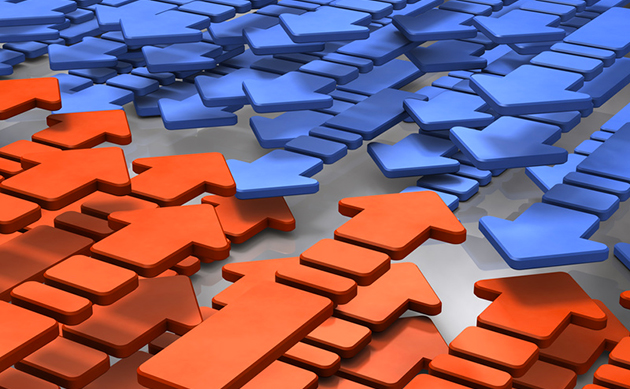
Quanto è influente l’analisi d’intelligence?Quanto è influente l’analisi d’intelligence?
metodi analitici e la performance dei suoi analisti, per quanto difficile da misurare e non esente da gravi errori, è verosimilmente tra le migliori al mondo[2]. Di conseguenza l’influenza dell’intelligence

Sinone. La spia ‘dietro’ al cavallo di TroiaSinone. La spia ‘dietro’ al cavallo di Troia
La storia del cavallo di Troia è indubbiamente una delle prime spy-story conosciute. Meno conosciuto è, invece, il nome della spia che mise in piedi l’inganno: Sinone.Sinone è l’antesignano della
