Valutazione del rischio e gestione della violenza da parte del partner nell’UE Gli agenti di polizia svolgono un ruolo di primo piano nella riduzione della violenza contro le donne da
Tag: Violenza
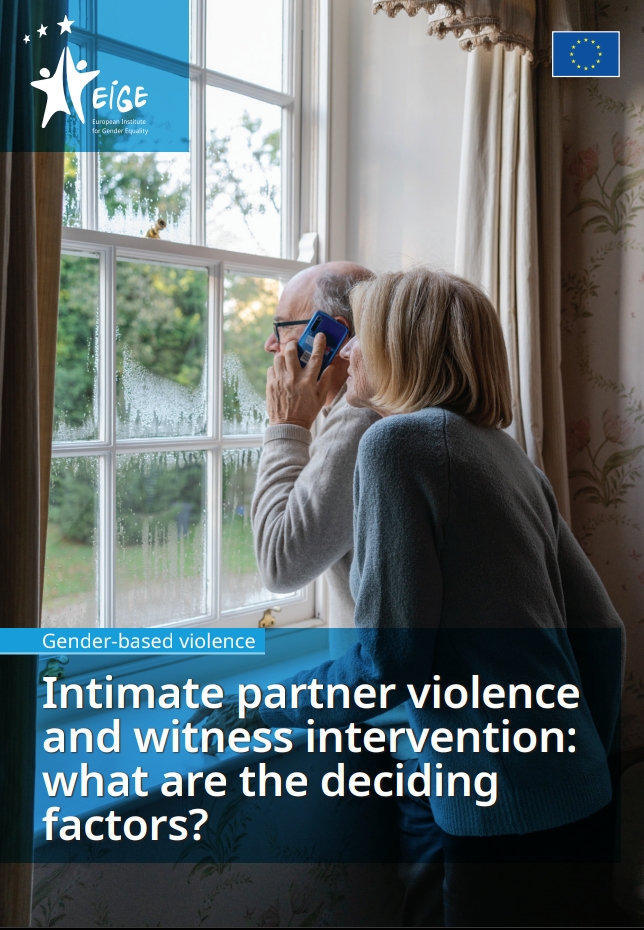
La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umaniLa violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani
L’UE ha da tempo riconosciuto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione basata sul genere che ha un forte impatto
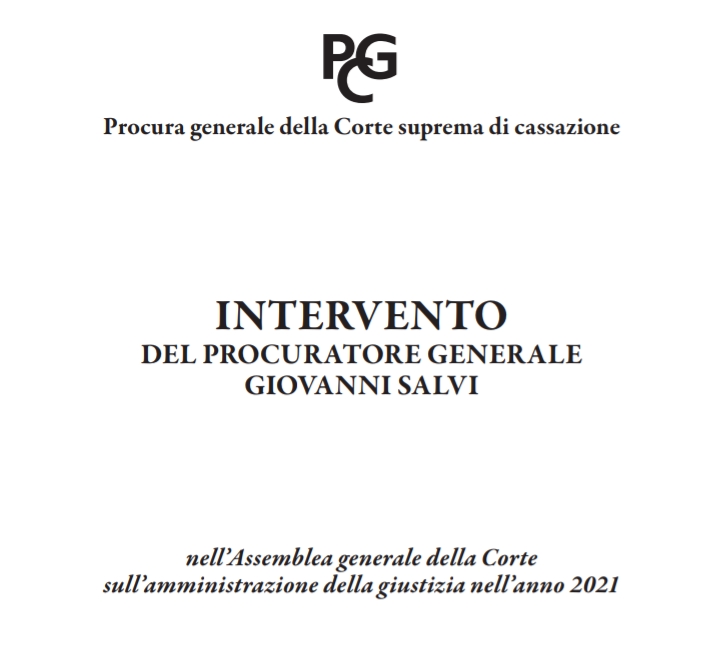
Violenza di genere relazione del Dr.SalviViolenza di genere relazione del Dr.Salvi
Relazione del dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, tenuta nell’ambito dell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, relativo al fenomeno della violenza di genere.

Bullismo e violenza di gruppoBullismo e violenza di gruppo
Spesso aggrediscono per il gusto di far male, di umiliare, per rimarcare una superiorità. Sottrarre un oggetto non è tanto una rapina fine a sé stessa, ma un modo per
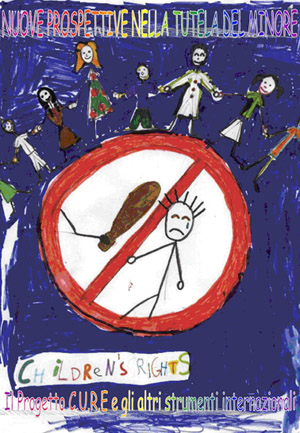
Tutela del minore: il progetto CURETutela del minore: il progetto CURE
CURE è l’acronimo di Children in the Union – Rights and Empowerment [I Minori nell’Unione – Diritti e Empowerment (autonomizzazione e responsabilizzazione)]. Il nome del progetto sta ad indicare che esso comprende
