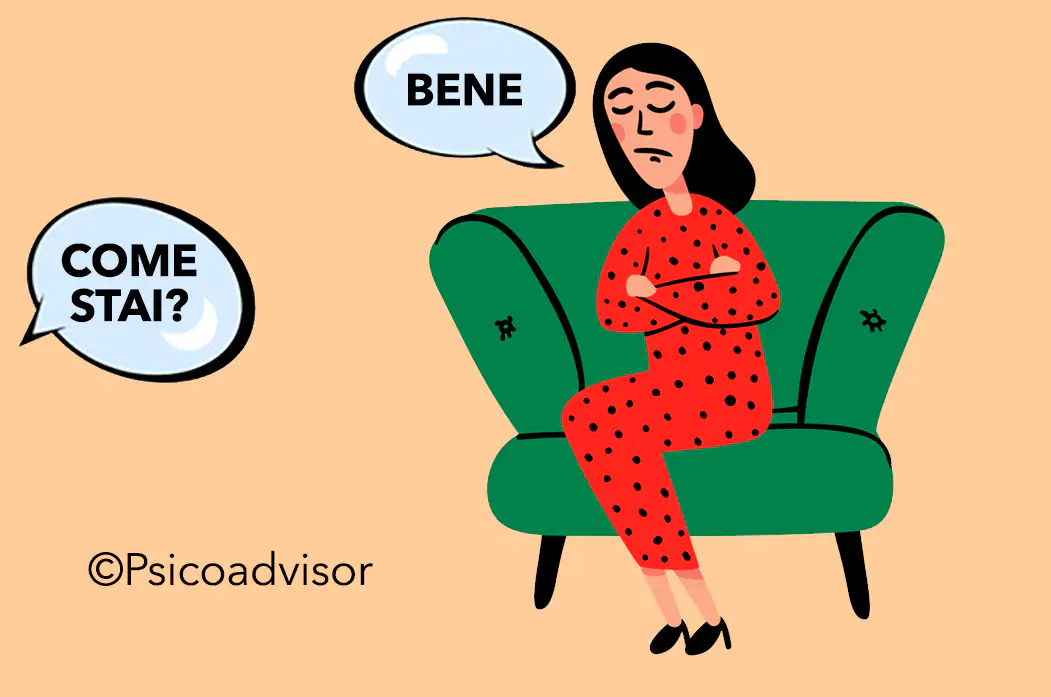La depressione altro non è che uno stato in cui l’individuo vive in totale assenza di speranza, speranza per sé e per il futuro, segnato dall’ineluttabile amarezza della vita. Già,
Giorno: 16 Ottobre 2022
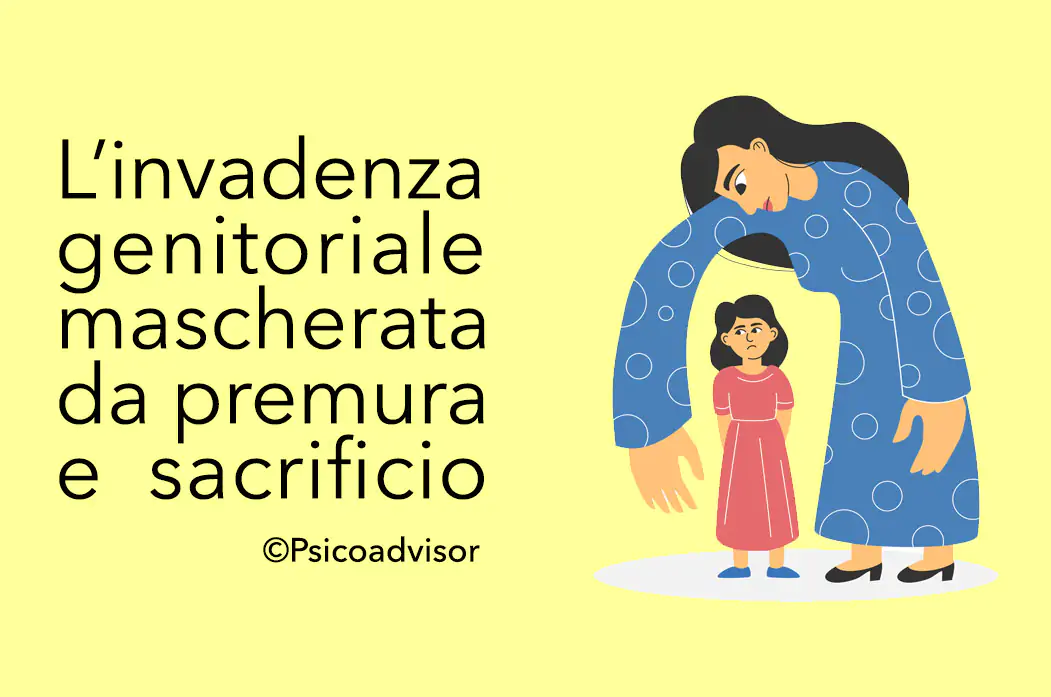
Comportamenti tipici dei genitori invadentiComportamenti tipici dei genitori invadenti
Essere invadenti non ha nulla a che vedere con l’essere premurosi. Un genitore può essere premuroso senza essere invadente. Queste prime due frasi sono doverose perché spesso, i genitori, celano
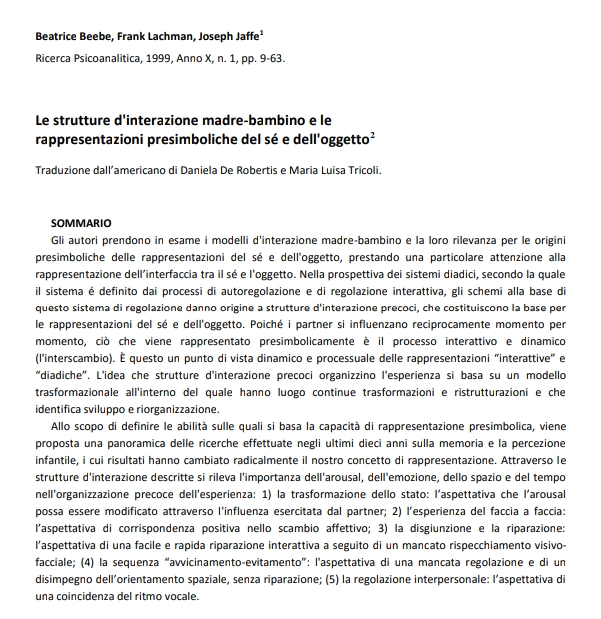
Le strutture d’interazione madre-bambino e le rappresentazioni presimboliche del sé e dell’oggettoLe strutture d’interazione madre-bambino e le rappresentazioni presimboliche del sé e dell’oggetto
SOMMARIO Gli autori prendono in esame i modelli d’interazione madre-bambino e la loro rilevanza per le origini presimboliche delle rappresentazioni del sé e dell’oggetto, prestando una particolare attenzione alla rappresentazione