Quanti sono le morti sul lavoro in Italia? Abbiamo voluto presentare questo Report, come OS OSSERVATORIO SICUREZZA nell’ambito delle molte iniziative del CAFISC, centro di alta formazione investigativa strategica e
Categoria: Cafisc

Osservatorio multiculturale per gli Immigrati a Gioia Tauro: iniziativa CafiscOsservatorio multiculturale per gli Immigrati a Gioia Tauro: iniziativa Cafisc
Nasce l’OmiCpi L’osservatorio multiculturale CPI comitato provinciale intercultura secondo un’idea della Dr.saa Anna Luana Tallarita PhD Cav.L’associazione CAFISC EJ UPECEJ è lieta di presentare la nascita dell’OmiCpi Osservatorio Multiculturale Immigrati
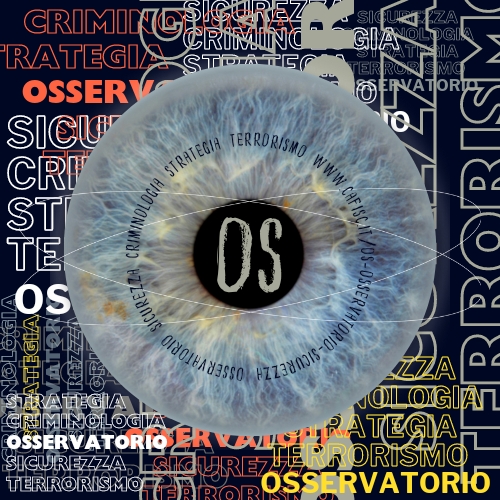
Il Report su carceri e suicidi dell’OS Osservatorio Sicurezza del CAFISCIl Report su carceri e suicidi dell’OS Osservatorio Sicurezza del CAFISC
Esce oggi 8 luglio 2024 il report dell’ OS osservatorio sicurezza del CAFISC intitolato: ” SITUAZIONE CARCERARIA IN ITALIADETENUTI E PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA : LE CARCERI E I SUICIDI,

CORSO ANTI-TRUFFA ONLINE PRESENZIALECORSO ANTI-TRUFFA ONLINE PRESENZIALE
Il Cafisc centro di alta formazione investigativa strategia e criminologia nell’ambito della più ambia gamma di offerte dell’ Ass. Cafisc EJ Upecej tra formazione continua in moti settori con Upecej
Bullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova leggeBullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova legge
Bullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova legge. continua a leggere: https://www.pcapolitical.com/2024/06/14/bullismo-e-cyberbullismo-dal-14-giugno-entra-in-vigore-la-nuova-legge/
Call for papersCall for papers
La presente a chiamata di articoli scientifici da pubblicare sulla nostra rivista dell’OS osservatorio sicurezza Le norme sono su: Inviate i vostri articoli (potete inviarne più di uno) La
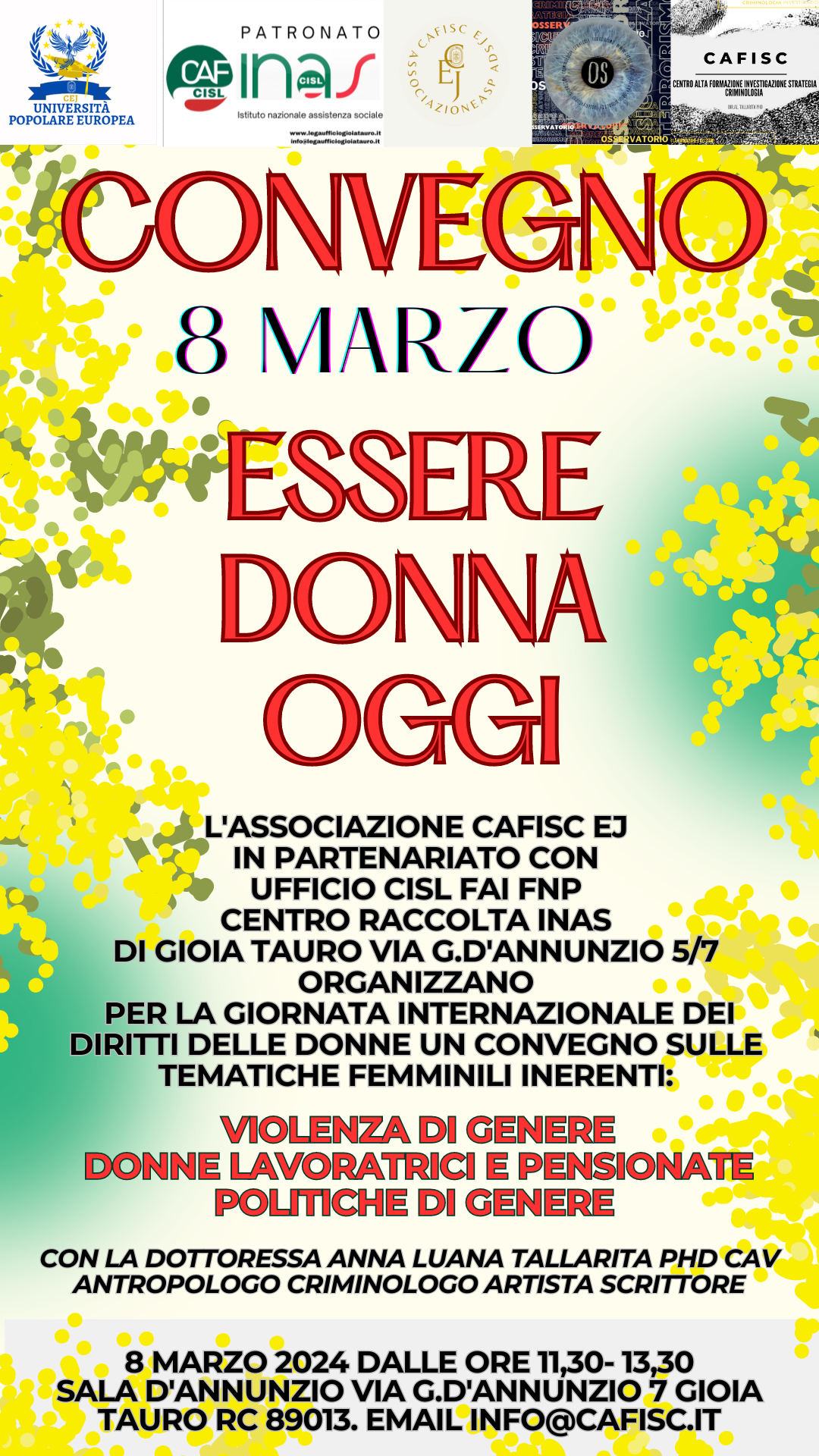
8 marzo Il Cafisc EJ organizza il CONVEGNO Essere Donna Oggi8 marzo Il Cafisc EJ organizza il CONVEGNO Essere Donna Oggi
Cafisc-EJ in partenariato con Ufficio CISL FAI FNP Centro raccolta Inas Gioia Tauro via G.D’Annunzio per la Giornata internazionale dei diritti delle Donne organizza il CONVEGNO: “ESSERE DONNA OGGI“ sulle

Attività Cafisc-EJ: formazione Marzo e Aprile corso lingua italiana per stranieriAttività Cafisc-EJ: formazione Marzo e Aprile corso lingua italiana per stranieri
L’associazione CAFISC EJ promuove una formazione di base per immigrati e stranieri lavoratori un corso di Lingua italiana con quattro giornate di incontri uno a settimana nel mese di Aprile

Laboratorio Farfalle sciolteLaboratorio Farfalle sciolte
Psicologia e Arte da un’idea del 2012 di ANNALUANATALLARITA PHD CAV